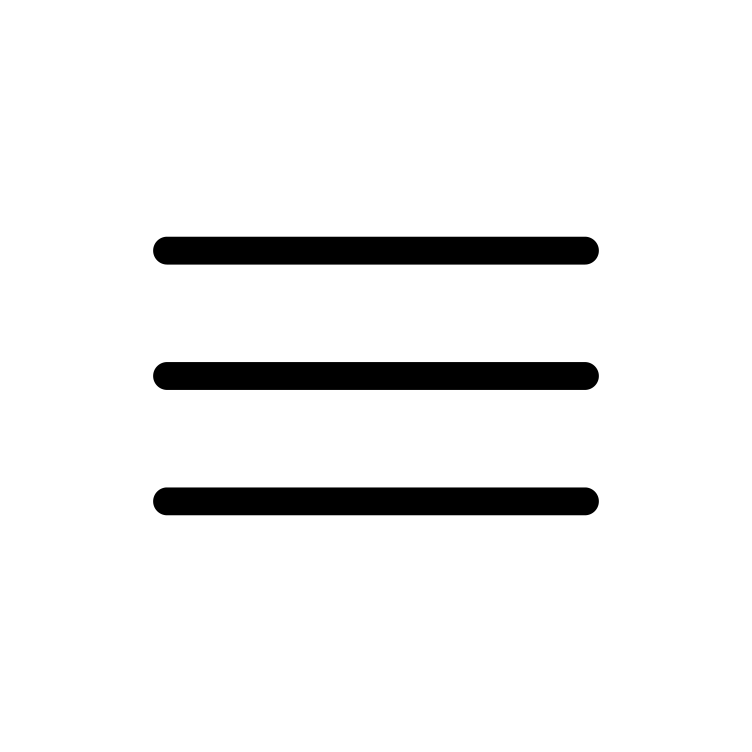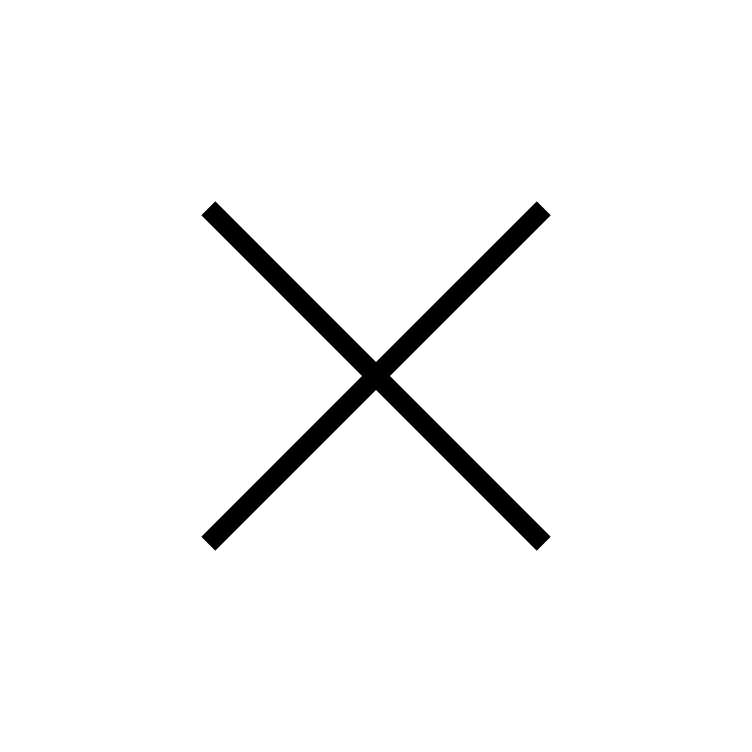Manifestazione per l'inaugurazione di Piazza Carlo Donat Cattin
Signor sindaco, autorità, signore e signori,
voglio dirvi, senza alcuna retorica, che ho accettato, davvero con piacere l'invito ad intervenire a questa manifestazione per dedicare una piazza di Finale Ligure a Carlo Donat Cattin.
Molti di voi conoscono la particolare amicizia, politica e personale, che mi ha legato per decenni a Carlo Donat Cattin. Essere qui oggi insieme a voi, ai suoi familiari è per me un'occasione davvero gradita e sentita. Ricordare Carlo Donat Cattin significa rivedere un'esperienza che ha attraversato la vita, le passioni e gli interessi, di milioni di italiani.
Una vita dedicata alla politica alta e franca è infatti qualcosa di più di un'esperienza, anche seria, di impegno in un lavoro. Una vita per la politica, come lo è stata per Donat Cattin e per molti dirigenti e militanti di quella stagione fondativa della nuova Italia, vuol dire un mondo di valori, di idee, di prassi che coinvolge i sentimenti, le emozioni, il carattere.
Se percorriamo all'indietro questo insieme di vita e politica troveremo le radici di molte questioni ancora aperte e di altre che, pur chiuse nella loro contingenza, tuttavia portano in sé risposte in grado di contribuire a trovare soluzioni adeguate alle difficoltà del tempo presente.
La prima grande questione è quella dell'impegno autonomo, responsabile, dei laici cattolici.
Un impegno che portò una parte del laicato cattolico ad impugnare le armi nella Resistenza.
Scelta terribile ma necessaria per salvare la libertà, per preservare la dignità umana e ricostruire lo Stato democratico e liberale lottando insieme a chi credeva in un altro paradiso in terra, a chi lavorava sinceramente per la democrazia ma la vedeva come un transito verso qualcosa di meglio: un impegno comune ma distinto che segna la grande frattura delle forze popolari all'indomani della fine della guerra civile.
Come don Lorenzo Milani, Donat Cattin ebbe sempre grande rispetto e stima e in casi non rari amicizia sincera per i comunisti che avevano dato il loro costoso contributo alla lotta partigiana ed alla affermazione di una nuova Italia antifascista e democratica, ma pensò sempre se stesso e la propria azione politica come indipendente e distinta nell'ispirazione e nei fini da quella della sinistra comunista.
La collaborazione, in fabbrica e nelle aule parlamentari, fu sempre ricercata e voluta come bene prezioso sia per radicare lo stile democratico sia per trovare soluzioni più avanzate nella tutela del lavoro e della sua centralità. Ma lo scontro sui principi e sulla gestione del potere non fu mai edulcorato.
Donat Cattin non fu mai ipocrita e la sua sincerità si spinse talora fino all'impopolarità, fino alla incomprensione, del resto messa nel conto come segno di contraddizione e di non conformismo. Fu un tratto tipico di una esperienza culturale e di prassi concreta e rigorosa.
Era profondamente convinto che si potesse convivere tra diversi e avere obiettivi di medio termine comuni pur differendo nell'ispirazione ideale, nella concezione spirituale. Un'idea che ha fatto molta strada, che ha consentito di sanare le fratture delle origini che tanto hanno ritardato la crescita del Paese ed insieme lo hanno costituito nella pluralità delle esperienze, nella ibridazione creativa.
Oggi può sembrare remoto il tempo in cui su grandi temi come la riforma agraria, lo sviluppo del Mezzogiorno, le alleanze internazionali, ci si divideva tra forze che avevano un comune riferimento identitario nel mondo del lavoro. Ed oggi, per fortuna, la grande ruota della globalizzazione e la fine di una storia imponente come quella che ha segnato il Novecento, consentono di rivedere il campo di azione delle forze riformiste e di costruire unità a partire da una più stringente valutazione dei bisogni e delle libertà. Oggi. Ma ieri la lotta era aspra e l'averla giocata con serietà e convinzione ha contribuito non poco a rendere più agevole l'esito attuale. Non a scolorire le distinzioni, a negare le differenze in nome della gestione del potere. Ma anzi a sottolinearle per alimentare identità concrete, correnti di pensiero e di idee che hanno favorito il pluralismo e l'autonomia delle forze sociali. Che anzi hanno fatto nascere in Italia l'idea di un mondo vitale, di un tempo nuovo di collaborazione anche conflittuale da cui nasce una nuova cultura democratica. Quell'idea che era propria dell'esperienza cattolico-democratica di un primato della società civile ordinata in partiti e correnti di pensiero, espressione di una ricchezza sociale non riducibile alla categoria dell'egemonia.
Un rifiuto di irregimentazione che esprimeva anche un dato del carattere di Donat Cattin, una capacità di guida, una caratura di comando non disgiunto dalla testimonianza. Valori e riferimenti ideali di cui avvertiamo la mancanza ed anche, acutamente, il bisogno.
In un tempo nel quale la vana chiacchiera tende a sovrastarci e a ridurre la serietà del lavoro politico a vuoto apparire senza sostanza, il ricordo di Donat Cattin ci incoraggia a riprendere la fatica dell'organizzazione della società civile in partiti che aspirano al bene comune. In partiti che non siano di cartapesta o confezionati sul paradigma del possesso, ma aperti alla partecipazione popolare, canali di crescita e di inventività, strumenti per la discussione e la decisione.
Il rispetto delle regole, la costruzione di una fecondità democratica che raccordi società e classe politica, erano il cruccio di Donat Cattin che in questo si incontrava con Moro.
L'idea che bisognasse allargare l'area del consenso democratico non solo per via parlamentare, per negoziato indispensabile tra forze politiche, ma anche dal basso, attraverso i canali della democrazia partecipativa, lo rendono molto attuale.
L'idea stessa di una democrazia deliberante, che dai luoghi di lavoro giunge fino ai punti nodali della decisione collettiva, è oggi un'idea viva che ha bisogno di lavoro e di passione. E può provocare rigetto nelle mediocri aree del consenso puramente esterno, di facciata, senza radici e senza durata.
Siamo in un tempo che è stato connotato dalla spettacolarizzazione, dall'evento, dal gesto. Un tempo assai poco sobrio e vero. Un tempo però nel quale vengono anche a maturazione aspetti profondi della politica sociale praticata già fin dalla fine degli anni '50 e poi approfondita nel confronto con le nuove istanze create dalla crescita, nel '68 e nel '69 e poi ancora negli anni '80.
Non possono certo essere percorsi tutti lineari. E si sbaglierebbe a fare dei nostri maggiori un santino da evocare solo in via celebrativa. C'è, nella capacità di rompere e poi di ricostruire, un coraggio ed una fermezza che cimentano le persone. Che riguardano la sostanza effettuale delle cose più che la raffigurazione di esse.
Le grandi narrazioni fascinatrici interessavano poco Donat Cattin: contava molto di più il lavoro paziente ed appassionato di costruire nuove fasi. Terza fase non a caso, sull'orma morotea, si chiamò la rivista ultima. Dopo Sette Giorni, dopo i convegni di Saint Vincent sempre alla ricerca di un ascolto autentico e convincente delle ragioni disattese, dei bisogni negati, della modernità falsificata.
Fase e tempo come luogo simbolico della piazza tornano oggi tra noi che intestiamo un'area di comunicazione e che speriamo divenga luogo di transito e di scambio di valori, idee, esperienze di vita reale, di gente reale. Poiché la semplice piazza virtuale del villaggio globale non può soddisfare una cultura concreta, pragmatica, che forse richiama tratti permanenti dell'origine ligure.
Ligure e piemontese, Donat Cattin era un testardo. Uno che non si smontava facilmente. Una persona legata alla parola data ed a quella seriamente ricevuta. Franchezza e serietà sono indispensabili del resto nel gioco duro del conflitto democratico. Quando si deve far fronte alle necessità dell'oggi senza smarrire l'identità e la visione.
In quella fase lontana da cui tutto ha avuto inizio, il mondo si spaccò in due. Un bipolarismo imperfetto che poteva contenere in sé i germi della dissoluzione della convivenza e di cui purtroppo rimane ancora, meno nel Paese che tra le forze politiche, un residuo amaro ed inacidito.
Da una parte coloro che, con De Gasperi pensano ad un partito democratico, ancorato ai valori occidentali ma non tutto immerso in essi, in grado di realizzare la concreta utopia del sistema nuovo in cui abbiano spazio e peso le classi storicamente emarginate. Dall'altra coloro che sentono come impossibile ogni costruzione più ampia e più partecipata dell'esercizio democratico e perciò vivono come un accerchiamento la presenza di una grande sinistra socialista e comunista. Da qui la rottura che lascia dentro il circolo democratico non le sole componenti liberali ma anche quelle di ispirazione solidarista e vede, dopo l'analoga frattura nel sindacato, la presenza indispensabile di una sinistra democristiana fondata sulla dottrina sociale della Chiesa autonomamente elaborata che consenta di fondare un partito di governo ma pluralista. In altre parole, che costruisca in concreto quel partito nazionale e popolare che Sturzo aveva immaginato e che solo il dopoguerra, con l'allargarsi del suffragio e la Costituzione repubblicana, consente di tentare di realizzare.
Rottura con la visione internazionale del più grande partito comunista d'Occidente, ma competizione per i valori di eguaglianza e giustizia iscritti nella comune elaborazione costituzionale: questo è in estrema sintesi il compito che la corrente sindacalista della Dc si assegna con Pastore prima e poi con Donat Cattin. E chi ne raccoglierà l'eredità dopo la morte.
Dimostrare che la visione egemonica del Pci sul popolo lavoratore italiano è infondata. Che la cornice entro la quale la visione di una giustizia sociale effettiva viene iscritta la deforma e la rende irrealizzabile, mentre è nella democrazia sociale, nello stato sociale di diritto che può realizzarsi quella promessa che la Costituzione contiene secondo l'efficace commento di Calamandrei.
Si accetta fino in fondo l'equilibrio sociale esistente, ma si considera la libertà di manifestazione pacifica, di espressione, di astensione dal lavoro come strumento potente di modificazione graduale e sensibile dell'assetto sociale. Una democrazia al lavoro, più che del lavoro, secondo l'intuizione feconda delle correnti liberaldemocratiche che contrasta con lo scetticismo di settori radicati della sinistra marxista, secondo cui addirittura ogni avanzamento può creare l'illusione della vittoria e scoraggiare la densità maggiore dei cambiamenti richiesti.
E' la storia di un lento ma costante emergere del riformismo sociale d'ispirazione cristiana che può assumere i toni della lotta di classe senza però mai accettare l'idea di uno scontro mortale e definitivo, ma lasciando anzi ben in vita l'antagonismo sociale come perno di libertà e garanzia di equità.
L'interclassismo diviene così una matrice di libertà economica ma soprattutto il motore di una trasformazione che modifichi a vantaggio dei ceti meno favoriti l'equilibrio raggiunto tramite la crescita. E' una visione non economicista anche se attenta ai fattori economici. Ha soprattutto natura sociale perché vede nei corpi intermedi e nelle autonomie territoriali il fattore propulsivo di una crescita democratica che garantisce l'equa distribuzione delle risorse.
E' qui una prima, decisiva considerazione sul valore della produttività. Rifiutata l'idea semplicistica che ogni aumento di produttività è puro sfruttamento, la coesione in azienda, specialmente nelle realtà meno gerarchizzate, consente il coinvolgimento dei lavoratori nella produzione e radica l'appartenenza alla comune fatica ma anche giustifica la distribuzione in forma contrattuale dei maggiori benefici ottenuti attraverso il progresso tecnico e lo sforzo produttivo comune.
Vale per la grande azienda, come insegna anche la dottrina socialista che vi vede l'area del mondo nuovo da realizzare al suo culmine con un capovolgimento finale delle parti, ma vale, in Italia, soprattutto per le aziende medie e piccole, quelle in cui si cimenta il genio nazionale, l'invenzione, l'accumulo artigianale di esperienza, la possibilità comunitaria.
E' in questa grande scelta di favorire i ceti medi produttivi, le piccole esperienze di trasformazione produttiva che si radica socialmente il lavoro di Donat Cattin sia da sindacalista che da politico e poi da Ministro del Lavoro. Il lavoro non è solo quello canonico della grande azienda fordista, rispettabile e significativo ma da moderare nella sua pretesa egemonica. E' invece soprattutto valore costituzionale aperto che include via via tutti coloro che investono, che ricercano, che rischiano.
La politica assume quindi il compito di accompagnatore, facilitatore, sostegno. Non può pretendere di invadere gli ambiti della famiglia, della comunità sociale, del lavoro. Ma deve saperli regolare in base al criterio di eguaglianza, potente motore di innovazione e di speranza. Aprire, alle forze sociali, alle politiche nuove, ai giovani, alle donne. Ma senza smarrirsi nella inconcludente percezione di un'uniformità senza pregio. Aprire senza perdersi e con se stessi perdere i valori di cui ci si arrischi a farsi portatori.
Un'identità, se è vera e vissuta, non si teme di perderla lungo il percorso del dialogo e del confronto tra correnti ideali. All'opposto, si mette in gioco in una competizione virtuosa con l'obiettivo di corrispondere ai "tempi nuovi" che, qui e oggi, ti chiedono nuovi approdi non per cedere ad una qualche esigenza di ingegneria politica ma per provare a dare risposte sempre più forti, adeguate, responsabili, costruttive.
Al Partito democratico, che decidiamo di costruire insieme ad altri la cui matrice culturale è diversa dalla nostra, guardiamo con questo spirito di apertura e con questa convinzione di solidità che non è presunzione o disegno di imposizione ma consapevolezza di presentarsi all'appuntamento forti di un patrimonio ideale che ha saputo misurarsi con la storia perché alla storia ha guardato con fiducia e speranza senza ritrarsi nella difesa dell'orto sicuro.
Signor sindaco, signore e signori,
è un fatto significativo che vogliate oggi dedicare una piazza. Un luogo dove si passa prima o poi tutti. Una metafora di una vita che è tanto più intensa quanto più si spende. Che si impiega senza inquadrarsi, che rifiuta la visione funzionale e organicistica. Che, insomma è vita vera e dura.
Come quella dei nostri pescatori, dei nostri lavoratori, degli imprenditori che producono ricchezza, dei politici infine, che sanno di essere servitori di un percorso che non è mai del tutto nelle loro mani ma che accettano la responsabilità di mettersi in gioco e di ricominciare sempre di nuovo chiedendo e chiedendosi, senza tregua: perché.